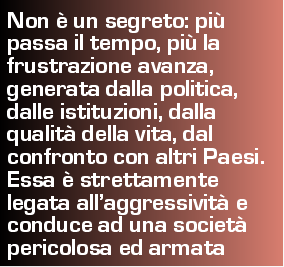HA LA MENTE DI DONALD MA TUTTO IL RESTO FA DA SÉ

Chi ha paura di Donald Trump? Da italiana, mi dà un non so che di certezze, come guidasse un robot di quei manga giapponesi, che a noi bambini dava sicurezze a prescindere da chi fosse l’umano che lo pilotasse: Mazinga, ad esempio, condotto da Tetsuya, ragazzo insicuro, dal carattere inquieto e solitario, una personalità difficile minata da un complesso di inferiorità derivantegli dall’essere orfano e dall’esigere dagli altri la stessa preparazione maniacale a cui lo aveva abituato il dottor Kabuto, costruttore del robot. Ma Mazinga era un porto franco di certezze e di vittorie, le paure erano solo umane, dunque giuste.
Un robot è necessario per ripristinare l’ordine. Ma che ci sia un uomo, dentro. Non temo Trump, temo la guerra. E temo per la salute degli americani, non solo quella psicologica. La cura Obama è stata un’esperienza di democrazia e respiro, soprattutto per i più ceti più bassi, ma non poteva durare a lungo, subito spazzata via da una «Trumpcare» che non piace nemmeno ai rappresentanti (la Camera statunitense ha approvato la riforma con 217 voti a favore e 213 contrari dopo averla sospesa per mancanza di voti, prima sconfitta del nuovo presidente, ed ora il Senato si prepara per una strada in salita di emendamenti ed accordi «aum-aum»). Sarà costosa principalmente per i contraenti che presentano già una malattia e per coloro che, in nome del diritto di scegliere se assicurarsi, andranno impavidi verso l’alea della libertà sanitaria. Fondi federali, gli «high-risk pools», per i malati gravi, manterranno bassi i costi delle assicurazioni della fascia media della popolazione (che Obama aveva contribuito ad alzare a favore della classi più povere) prestandosi al rischio di lunghi periodi di attesa per i pazienti prima che le spese sanitarie siano pagate dallo Stato.
Intanto, procedono i lavori di costruzione del muro di Trump, 3.220 chilometri di confinamento e 9 metri di altezza, dove gli operai lavorano con giubbotti antiproiettile e solo una piccola parte di circa mezzo milione di imprese edili di proprietà ispanica ha preso in considerazione l’appalto; se lo ha fatto, è stato (si giustificano) perché il lavoro è lavoro. Secondo la National Autonomous University of Mexico, inoltre, la costruzione del muro metterebbe a repentaglio la vita di 800 specie animali autoctone, 180 delle quali già a serio rischio di estinzione. L’Italia sta a guardare indignata, ma la situazione, mutatis mutandis, non è migliore. Il muro è un muro psicologico, fondamentalmente. Lampedusa, porto di scarico degli scafisti mediterranei et altera. Al sindaco del piccolo comune siculo, Giusy Nicolini, è stato conferito il Premio Unesco Houphouet-Boigny sulla ricerca della pace «per aver salvato la vita a numerosi rifugiati e migranti e averli accolti con dignità».
L’accoglienza, come quella in un villaggio turistico, è una cosa; la vacanza un’altra. Gli immigrati giungono in Italia e sono raccolti con quello che in un villaggio vacanze è un calice di prosecco. Poi resta solo il secco: è l’inizio di una vacanza tormentata, in un Paese ostile, perso, disorganizzato. Si configurano tutti gli estremi per un danno da vacanza rovinata. L’italiano li detesta perché vendono rose e cartine la sera, spacciano, lavano forzatamente i vetri al semaforo, chiedono soldi sotto forma di ricatto nei parcheggi e, quando va bene, dietro le quinte muovono le fila delle cucine di ristoranti italiani, giapponesi, francesi, pur non sapendo dove siano il Giappone dei manga e la Francia della nouvelle cuisine. Il «bangla» va anche di moda quando può, e nei quartieri è spesso accettato, considerato come un vecchio conoscente, per due chiacchiere e una liquidazione veloce; pezzo di arredamento del rione, conduce una vita oscura di cui nessuno sa nulla. Risuona il sempreverde luogo comune: «Se ancora vendono rose dei cimiteri, qualcuno che le compra ci sarà», e non sono i morti. Io, quella degli italiani, la chiamo ipocrisia.
Il procuratore della repubblica Carmelo Zuccaro dà intanto indicazioni per consentire un miglior controllo dell’attività della navi Ong, mosso anche dall’evidenza che alcune di esse spengono il transponder per non farsi localizzare, e propone la presenza di ufficiali di polizia giudiziaria su tali navi (non per controllarle, bensì per fare quei rilievi che il personale delle Ong non è autorizzato a compiere), aggiungendo: le navi Ong non dovrebbero battere la bandiera dello Stato in cui sono varate e acquistate, ma quella dello Stato in cui la Ong ha sede. Si muovono gli attivisti a difesa dei rifugiati; spesso sono gli stessi che pretendono il crocefisso appeso con il Cristo morto nelle aule di scuola dei propri figli. Ma Dio è morto, per l’appunto.
Non è più una questione di destra o di sinistra, di cattolicesimo o burka, ammettiamolo: siamo terrorizzati dagli extracomunitari. Dio è morto, Mazinga è morto. Ed è morto l’ambulante senegalese Maguette Niang, causa un infarto durante una corsa con la busta piena di borse per sfuggire al blitz anti-abusivi dei vigili romani, indagati poi per omicidio colposo in un contesto politico che non tutela le zone di pregio. E mentre il Governo parla di una legittima difesa notturna, secondo cui è possibile utilizzare un’arma da fuoco «di notte» e non di giorno; mentre Renzi, appena rinominato segretario del suo partito, fa un passo indietro viste le reazioni scaturite dall’approvazione alla Camera di una norma illogica; mentre Matteo Salvini grida «vergogna!» e Silvio Berlusconi si oppone all’emendamento; mentre il capoverdiano Edson Tavares, già denunciato per maltrattamenti, a Rimini sfregia per sempre con l’acido la fidanzata ventottenne Gessica Notaro, ex Miss Romagna; mentre in centro a Roma si consuma un amplesso in pieno giorno davanti la sede del celebre palazzo occupato dell’ex Federconsorzi, che attende lo sgombero da oltre tre anni e il cui proprietario continua, suo malgrado, a pagare le tasse; mentre accade questo ed altro, si guarda al presidente Usa come a un detestevole marziano, perché ha elevato due muri, uno fisico, l’altro sanitario. Ed altri ne eleverà.
Continuo a credere ai cartoni animati anni 80. L’ordine può essere ripristinato solo dai vecchi robot. I nuovi sono fallaci: i social network non contengono un pilota, ma milioni di parole al vento. Papa Bergoglio sprona all’accoglienza, e riceverà Trump in Vaticano il 24 maggio, poco prima del G7 di Taormina; sarà quindi atteso da Sergio Mattarella. Dichiara il tycoon: «La tolleranza è la pietra miliare della pace. Per questo sono orgoglioso di fare uno storico annuncio questa mattina, e condividere con voi che il mio primo viaggio all’estero come presidente sarà in Arabia Saudita, poi in Israele e poi in Vaticano a Roma». Le origini tedesche possono metter paura, come anche la sua ricchezza (autoprodotta attraverso i suoi stessi sforzi, quelli del padre Fred, quelli del nonno Friedrich, semplice barbiere immigrato negli States).
Sarà l’età, ma a me piace immaginare Donald guidare Mazinga come faceva Tetsuya, rinchiuso in un robot di artiglieria pesante, pericolosa, ma che spesso salva la vita di un pilota insicuro. Il punto è: vogliamo essere un cavallo di Troia o un robot? Vogliamo aiutare o essere aiutati? Perché non si può avere tutto: Mazinga ha la mente di Tetsuya ma tutto il resto fa da sé. (ROMINA CIUFFA)
Anche su Specchio Economico – maggio 2017


 New York. Si lamenta perché, dice, in America non si parla che l’americano. Dice che le scuole, i media, i cervelli sono, monopolizzati. Si sente italiano più che americano e, a dirla tutta, in Italia c’è stato solo pochi giorni che, contati su 49 anni, non lo rendono proprio italiano. Ma dice «grazie assai» e «statte buono». Ascolta Lucio Battisti, Rita Pavone, Daniele Silvestri, Vasco Rossi. «Sonno» lo pronuncia «sono», e «gente» per lui è un plurale. Non è alto e in America questo non fa onore, soprattutto quando si tratta di giocare a basket. Ha occhi scuri, capelli scuri, cuore scuro. Suo padre è morto. Sua madre vive nell’America più profonda. Entrambi sono nati calabresi. I suoi nonni erano emigranti e così hanno dato alla famiglia una possibilità di crescere.
New York. Si lamenta perché, dice, in America non si parla che l’americano. Dice che le scuole, i media, i cervelli sono, monopolizzati. Si sente italiano più che americano e, a dirla tutta, in Italia c’è stato solo pochi giorni che, contati su 49 anni, non lo rendono proprio italiano. Ma dice «grazie assai» e «statte buono». Ascolta Lucio Battisti, Rita Pavone, Daniele Silvestri, Vasco Rossi. «Sonno» lo pronuncia «sono», e «gente» per lui è un plurale. Non è alto e in America questo non fa onore, soprattutto quando si tratta di giocare a basket. Ha occhi scuri, capelli scuri, cuore scuro. Suo padre è morto. Sua madre vive nell’America più profonda. Entrambi sono nati calabresi. I suoi nonni erano emigranti e così hanno dato alla famiglia una possibilità di crescere.