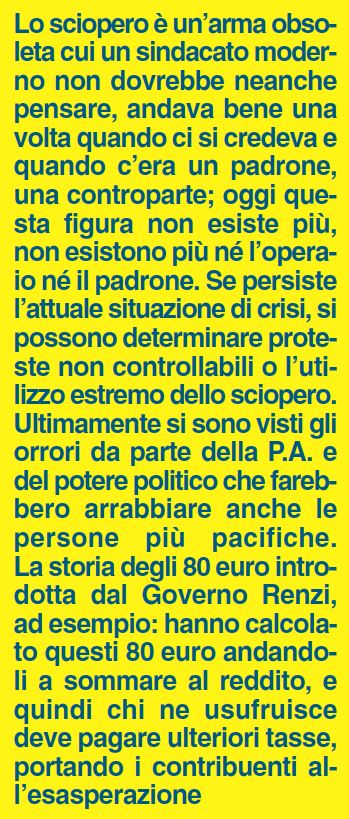ADDIO ANTONIO MARINI, MORTO SUPERSTITE DEI TERRORISTI
di ROMINA CIUFFA (22 agosto 2019). Fino alla fine un superstite, un sopravvissuto alla giustizia-come-si-deve, quella del tempo che fu, che fino all’ultimo non è stato ucciso da chi lo voleva morto. Lo si conosce come l’uomo dell’antiterrorismo, il Pubblico Ministero con PM maiuscole come in un bravo codice di procedura penale; io lo conosco come colui che, pur vedendomi crescere, mi chiamava “direttore”. Non una figura a caso nel patrimonio meteoritico italiano e mondiale della Giustizia, anche l’uomo che ha regalato a Papa Wojtyla il proiettile che non lo uccise, sottraendolo ai reperti giudiziari perché, a fini processuali, non serviva più. Se lo diceva lui, era così. E in questo modo fece sì che quel frammento di piombo fosse incastonato, come voleva Giovanni Paolo II, nella corona della Madonna di Fatima. A tutt’oggi.

Oggi che Antonio Marini non c’è più da ieri, 21 agosto. I giornali si sono precipitati a pubblicare i loro coccodrilli, tutti uguali, nessuno distinto, e probabilmente già pronti essendo lui portatore di un male inesorabile che, per il principio di non contraddizione, non lo ha scalfito minimamente nell’essere, lasciandolo – come sempre – nel suo umore e nella sua forza.
Ne sono testimone: mi chiamava carico di intenzioni, di costanza, mandava messaggi e foto, e parlava di futuro. Suo e del suo libro, la raccolta degli articoli sul terrorismo che lo hanno reso da sempre un grande collaboratore del nostro Specchio Economico, progetto che aveva quasi terminato con il direttore Victor Ciuffa ma che la scomparsa di quest’ultimo fermò. O meglio, rallentò. Ogni mese, per decine di anni, Marini scriveva per noi due rubriche: Giustizia e Terrorismo. Con costanza e attualità, con il senso del tempo e l’importanza di fissarlo.

Umilmente consapevole di non essere uno qualunque, non un “comune mortale”, nel combattere – prima come Procuratore generale facente funzioni, poi avvocato generale della Corte d’appello capitolina – delicate lotte in delicati processi come quelli sull’attentato al Papa, sulla strage della scorta di Aldo Moro in via Fani e il di lui omicidio, sulla morte della studentessa della Sapienza Marta Russo, sull’agguato, firmato dalle nuove Brigate Rosse, costato la vita al giuslavorista Massimo D’Antona.
Alcuni suoi processi sono raccolti nel suo sito in un’apposita sezione: http://www.antoniomarini.com/processi-2/. Il libro voluto da lui e da Victor Ciuffa sul terrorismo uscirà entro l’anno.
Marini muore “in sordina” perché è il giorno in cui, caduto il Governo, se ne attende uno nuovo (i veri eroi non amano essere notati). E così è per me più opportuno dar conto, con le sue stesse parole negli anni, di come si sia sviluppata quella politica (nello specifico antiterroristica) che è anche alla base del cambiamento di oggi in tema di “straniero”.
Ricordando che mi chiamava ogni volta e mi diceva: “Direttore, ti ho mandato l’articolo. Leggilo e dimmi cosa ne pensi”.
- “Ci si chiede: quanta libertà siamo ancora disposti a sacrificare in nome della sicurezza?”, (ottobre 2006);
- “Uno dei nodi ancora da sciogliere nella lotta al terrorismo internazionale è la definizione stessa di terrorismo (…)”, (novembre 2006);
- “Ora, non v’è dubbio che la costituzione delle unità investigative interforze costituisca un importante passo in avanti nell’azione di contrasto del terrorismo internazionale e che, ferma restando l’assoluta libertà del pubblico ministero di avvalersi di altre strutture di polizia giudiziaria nello svolgimento delle indagini, tali unità sapranno fornire un contributo particolare all’accertamento dei delitti più gravi di terrorismo. (…) Le unità antiterrorismo non hanno ancora visto la luce, mentre la pianta malefica del terrorismo internazionale cresce invece a vista d’occhio giorno dopo giorno. A quanto pare, si teme di provocare un accavallamento di competenze e una dispersione del patrimonio investigativo o, peggio ancora, una trasfusione sul piano giudiziario di attività che sono principalmente mirate alla polizia di sicurezza. Ma forse la ragione del ritardo è un’altra. Mancano le risorse finanziarie necessarie a rendere operativo il progetto, risorse che dovrebbero essere individuate e reperite da ministri degli Interni in quelle già disponibili, senza generare nuovi capitoli di spesa. Come al solito la coperta è troppo corta: in mancanza di nuovi fondi, se si copre una parte si rischia di scoprire l’altra (…)”, (gennaio 2007);
- “L’esperienza accumulata in questi ultimi anni nella lotta al terrorismo dimostra che la comunicazione via internet costituisce uno dei mezzi più efficaci e meno controllabili per organizzare cellule terroristiche e fare proselitismo (…)”, (gennaio 2006);
- “Mentre le esigenze di prevenzione e di repressione del terrorismo anche internazionale non possono assumere alcun rilievo relativamente al rispetto di alcuni diritti intangibili e assoluti, esse possono però giustificare l’adozione di misure restrittive incidenti sull’esercizio di altri diritti, purché siano soddisfatte le condizioni all’uopo previste dalle singole disposizioni che li tutelano (…)”, (luglio 2007);
- “Insomma, è tempo di gettarsi dietro le spalle le due tragiche ideologie che hanno dominato il secolo scorso con il loro delirio totalitario. Quanto agli ex terroristi, è tempo che smettano di cercare tribune da cui esibirsi, fornire la loro versione dei fatti, tentare ancora subdole giustificazioni. Lo Stato democratico che intendevano abbattere si è mostrato fin troppo generoso nei loro confronti. Pur avendo il diritto di reinserirsi nella società dopo aver pagato i conti con la giustizia, devono farlo con discrezione e misura, senza mai dimenticare le proprie responsabilità morali che non sono meno importanti di quelle penali (…)”, (giugno 2008);
- “Così come non dovrebbero dimenticare le proprie responsabilità morali anche coloro che hanno contribuito a teorizzazioni aberranti e a campagne di odio e di violenza da cui sono scaturite le peggiori azioni terroristiche, ovvero hanno offerto al terrorismo motivazioni, attenuanti, coperture e indulgenze fatali. Il riferimento ai «cattivi maestri» e ai tanti fiancheggiatori rimasti impuniti appare evidente (…)”, (giugno 2008);
- “L’esigenza di combattere il terrorismo non fa venire meno il divieto di estradare o; di espellere lo straniero dal territorio dello Stato quando esistono seri e concreti motivi per ritenere che esso corra il rischio reale di essere sottoposto, nel Paese di destinazione, a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (…)”, (settembre 2008);
- “Configura il delitto di «atto di terrorismo», previsto e punito dall’articolo 280 bis del Codice penale, aggravato dalla finalità di eversione dell’ordine costituzionale, la collocazione di un ordigno micidiale sul davanzale di una finestra dell’ufficio elettorale del candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica (…)”, (settembre 2010);
- “Si va consolidando la tendenza a considerare il territorio europeo non più solo un riparo e una retrovia logistica, ma anche un teatro operativo e una base per pianificare iniziative da consumare altrove (…)”, (dicembre 2010);
- “È, però, principio centrale del diritto internazionale dei diritti umani che esso debba tenere il passo con il mondo che cambia. Alcune delle più gravi violazioni dei diritti umani sono oggi commesse da o per conto di attori non statali che operano in situazioni di conflitto di un tipo o dell’altro, anche mediante reti terroristiche nazionali o internazionali. Di qui l’esigenza di adeguare la normativa alla realtà, riconoscendo le vittime degli atti di terrorismo come vittime di gravi violazioni di tale diritto (…)”, (ottobre 2012);
- “Il prolungarsi della crisi economica aumenta i fattori di rischio sul fronte dell’eversione e del terrorismo (…)”, (maggio 2013);
- “Non v’è dubbio che l’Isis, a differenza di altri gruppi terroristici che combattono in Iraq e in Siria, abbia un grande «appeal» tra i giovani stranieri, spesso occidentali (…)”, ottobre 2014.

Non solo il grande PM Marini. Anche un uomo di mondo, che amava l’Opera e le prime, le cene tra amici, perché no la mondanità sic et simplicter ma sempre e comunque colta, le presentazioni dei libri, gli incontri ad altro livello, i salotti di un certo tipo (frequentatore assiduo di quelli di Anna Maria Ciuffa, sempre in prima linea nel giro dei grandi invitati), le alleanze mentali, le rivelatrici disquisizioni su Italia ed internazionale con tutti, ma anche chiacchierate alla mano, contraddistinte da serietà, giocosità, buon umore, dolcezza, energia (insignito anche del Premio Simpatia 2015 nella Sala del Campidoglio). Sempre con la moglie Elisabetta, una coppia nota nel mondo romano ed italiano per intelligenza ed affettuosità, classe, presenza (spesso ritratta sul Dagospia di Roberto D’Agostino).
Per me il Palazzaccio, la Corte dove mi riceveva e restavamo a parlare per lungo tempo al fluire del Tevere. Per me la promessa di portarmi al Carcere di Regina Coeli, che non conoscevo, sapendo che avevo esercitavo da psicologa in quello di Rebibbia. Per me, giurista e penalista, ma soprattutto grande costituzionalista, un esempio da seguire.

Andato in pensione solo nel 2015, ricevendo subito il Premio alla Carriera Giudiziaria e il Premio Colosseo D’oro. La nuova, più definitiva assenza di Antonio Marini lascia un vuoto invalicabile nel panorama intellettuale e culturale italiano e nella lista di coloro che possano essere consultati per “capire cosa fare”, soprattutto in un momento – quello odierno – in cui mancano combattenti tanto da non esserci nemmeno un voto, e così, con essi, le idee e l’onestà intellettuale, l’esperienza, il coraggio, l’animo. Viene meno un giudice, un uomo di legge, un lottatore, un sentimentale, un romantico, un cervello, un amico.
Solo un terrorista non è riuscito a sconfiggere, ma lo si ricorderà per quelli che ha fermato. In tutti i casi incluso l’ultimo, risolutivo, con una costante: senza paura. (Romina Ciuffa, il tuo direttore e la tua amica)


















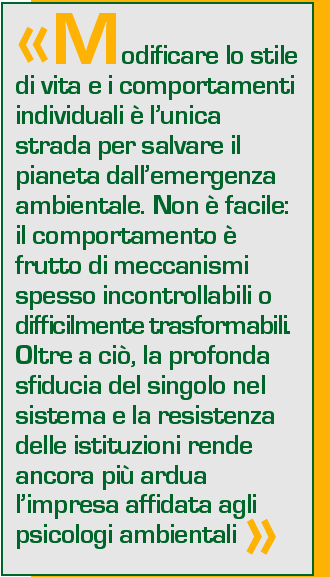

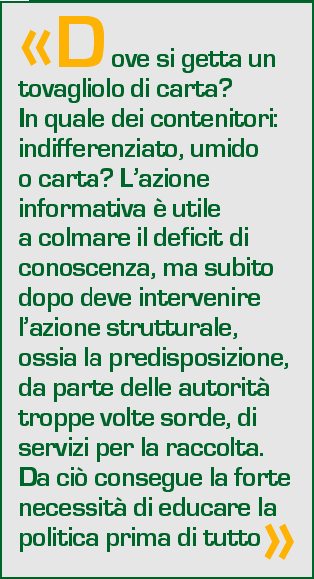






































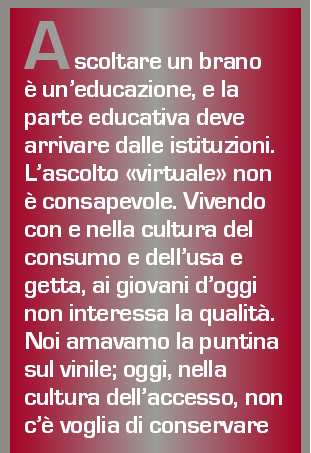




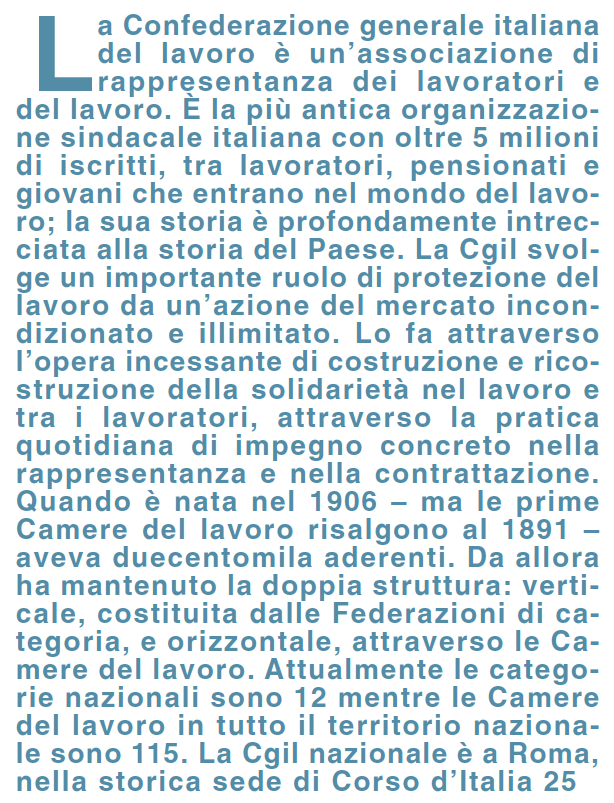

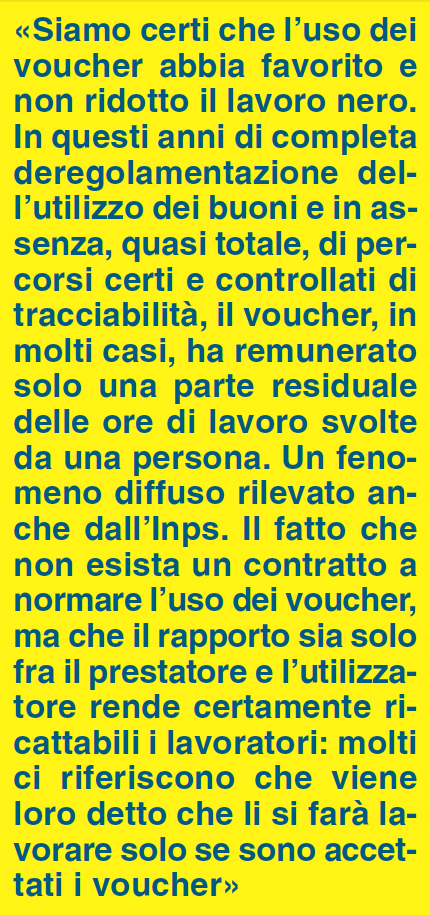






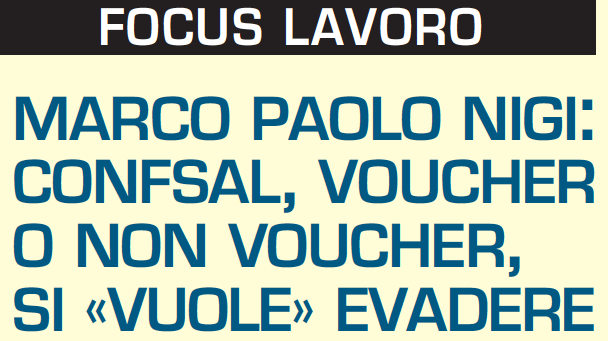
 Per lui, il sindacato è una scuola di vita. Scuola anche perché è dalla scuola che proviene, come professore. Segretario generale della Confsal, principale Confederazione dei sindacati autonomi, e dello Snals, storico rappresentante dei lavoratori della scuola, spiega la sua visione tout court sullo stato generale del mondo del lavoro, a partire dai famigerati «voucher».
Per lui, il sindacato è una scuola di vita. Scuola anche perché è dalla scuola che proviene, come professore. Segretario generale della Confsal, principale Confederazione dei sindacati autonomi, e dello Snals, storico rappresentante dei lavoratori della scuola, spiega la sua visione tout court sullo stato generale del mondo del lavoro, a partire dai famigerati «voucher».