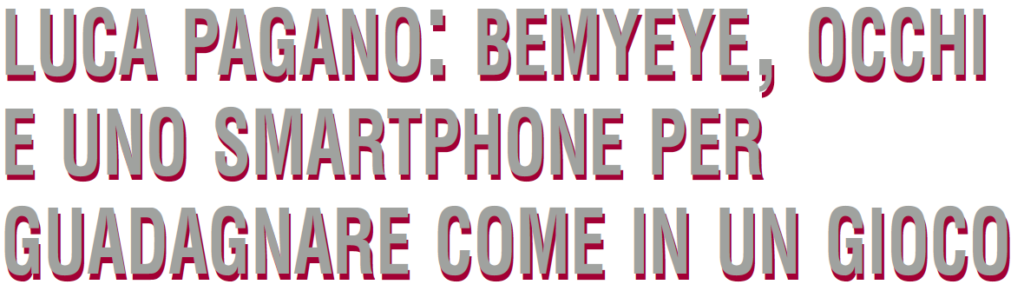

Siamo in un videogioco e giochiamo. Ma la cosa interessante non è «partecipare» né, tantomeno «vincere», bensì «guadagnare». Abbiamo delle missioni da compiere e dei livelli da superare, per guadagnare di più; possiamo anche regredire (ma perdere le vite, mai). Non dobbiamo scalare montagne o uccidere i nemici: dobbiamo solo usare lo smartphone per inviare posizione e foto di ciò che vediamo. Siamo gli occhi. Noi, siamo «Eyes».
È questo BeMyEye, sii il mio occhio. L’occhio delle aziende che hanno necessità di controllare l’adempimento di certi contratti, di verificare che il loro cartellone sia affisso correttamente e, a maggior ragione, sia presente su un pannello della pensilina vicino casa di chi lo fotograferà, in conformità dei piani concordati con i distributori; o di accertarsi che una farmacia non abbia relegato il proprio prodotto in un cassetto; o che l’autoconcessionaria presenti la vettura in modo consono alla vendita. E così via.
«La tua missione consisterà nel raccogliere informazioni e immagini circa promozioni, prezzi ed esposizione dei prodotti. Alcuni dei nostri clienti richiedono anche attività di mystery shopping e pareri sulla tua esperienza d’acquisto. La maggior parte dei job richiede non più di 10 minuti del tuo tempo!», ed è fatta: ad ogni missione corrisponde un compenso, previa approvazione, ed è possibile guadagnare discrete somme impegnandosi da qualche minuto a qualche ora al giorno, o quando si vuole, in ogni città, in ogni luogo, in Italia e all’estero. Praticamente, oggi che si discute di Job’s Act e di disoccupazione, è una rivoluzione, o meglio: un faro.
Nel 2011, da Milano, Gian Luca Petrelli aveva bisogno di informazioni per se stesso, e immaginò BeMyEye, soluzione DaaS (Data as a Service) di «mobile crowdsourcing» per ottenere informazioni sulla vendita al dettaglio. Quindi, si rese conto che ciò potesse essere utile anche alle altre aziende, ed ecco altri manager – David Miller, Imran Khan, due anni fa anche Luca Pagano, attuale amministratore delegato -. Ecco i finanziamenti. Ed ecco le foto: più di 2 milioni raccolte da circa 400 mila «Eyes» che hanno scaricato l’App. Ed ecco i clienti: Mattel, Coca Cola, P&G, Nestlè, Samsung, Lavazza, Universal, Barilla, Nespresso, Tim, Heineken, Twentieth Century Fox, e moltissimi altri che hanno scelto BeMyEye per ottenere informazioni affidabili e processabili, potendo così osservare migliaia di location in pochi giorni, offrendo «insight» per identificare nuove fonti di business, per rafforzare l’identità del marchio, per monitorare gli accordi commerciali. Voilà.
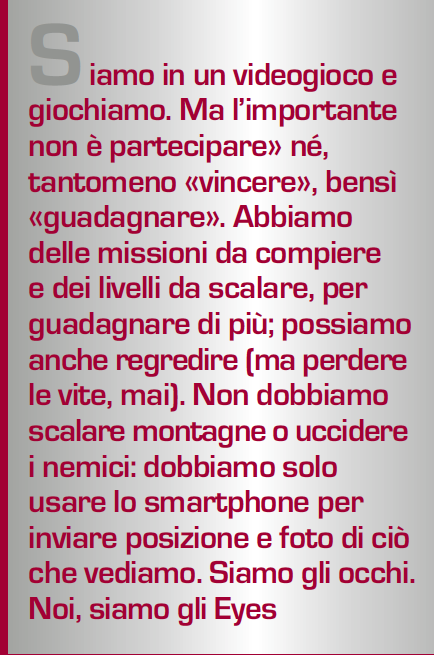
BeMyEye ha la sede centrale in Gran Bretagna e uffici in Italia, Francia e Spagna, è una compagnia partecipata da grandi venture capital europei. Nauta Capital, p101 e 360 Capital Partners nel 2016 hanno conferito un finanziamento di 6,5 milioni di euro con cui la compagnia ha accelerato lo sviluppo del prodotto ingrandendo il team. Il finanziamento è stato utile anche a rafforzare la divisione vendite e marketing e supportare l’espansione internazionale dell’azienda. Così, sia la sede sociale che il quartier generale sono stati spostati a Londra, ed ora la società è a tutti gli effetti una società di diritto inglese. Ed ha anche acquisito LocalEyes, una delle maggiori compagnie di «crowdsourcing» in Francia, per superare i 400 mila collaboratori on-demand e posizionarsi come la più importante realtà europea nel crescente mercato della raccolta dati e immagini dal mondo reale tramite l’impiego di cellulari da parte degli utenti sottoscrittori.
BeMyEye si fonda, infatti, sull’impiego di un’App gratuita che utilizza tecniche di «gamification», ossia «come in un gioco», e consente di accumulare in maniera anche divertente piccole somme di denaro in cambio di micro-lavori da svolgere su base volontaria nei luoghi scelti attraverso la localizzazione. In tal modo sta costruendo un grande network europeo di rilevatori on-demand, occhi delle imprese che si rivolgono all’azienda di Petrelli necessitando di informazioni dai punti vendita o dal livello strada. Con questo metodo, le aziende richiedenti possono vedere, con gli occhi degli Eyes, migliaia di luoghi diversi in pochi giorni. Pagano (nella foto qui sotto) precisa come.

Domanda. Una delle principali e più innovative «start up» italiane, ma già è «adulta», sebbene guidata da giovani. Come definisce, allora, BeMyEye?
Risposta. Tengo a definirla non più come una start up, poiché la nostra ormai è un’azienda che ha 6 anni di vita, copre 10 Paesi, ha uffici a Milano, Parigi, Londra, Madrid, ha raccolto 10 milioni di capitali. Siamo 50 persone con un’infrastruttura dei processi e un’organizzazione che ci fa somigliare più a una giovane azienda in crescita che non ad una start up.
D. Come è sorta l’idea di canalizzare i singoli intorno a missioni a pagamento per soddisfare le esigenze di grandi compagnie?
R. BeMyEye nasce da un’idea geniale del fondatore, Gian Luca Petrelli, che ha creato il business da una sua esigenza personale: quella di controllare se l’olio prodotto dalla sua azienda di famiglia veniva correttamente promosso nei negozi di Whole Food negli Stati Uniti, cosa che lui non riusciva a fare attraverso le agenzie tradizionali a prezzi ragionevoli. Così si rivolse al fondo più importante d’Italia, il 360 Capital Partners, ed ottenne il finanziamento per concretizzare il prodotto. Successivamente, nel 2013, BeMyEye ha cominciato a commercializzarlo e si è visto che effettivamente funzionava.

D. Perché funziona?
R. Perché è un modo totalmente innovativo che «bypassa» completamente il modello tradizionale di rilevamento dei dati sul territorio o in un punto di vendita, mettendo direttamente in connessione i «brand» e i «retailer», che hanno bisogno di ottenere dati relativi ad una specifica location, con persone che si trovano in prossimità di quella location e hanno uno smartphone in tasca, dando loro un compenso: noi li abbiamo chiamati «Eyes», occhi. A loro diamo missioni da svolgere come se fossero in un gioco.
D. Le chiamate «missioni»: cosa sono?
R. Un esempio: l’Eye, che prenota dal cellulare una missione a sua scelta, deve entrare nel negozio e trovare un prodotto o una certa promozione, verificarne la presenza e il corretto posizionamento, fare delle fotografie o scansionare il codice a barre. Se l’Eye ha successo viene ricompensato con denaro. Ci sono missioni più veloci, compibili in meno di un minuto, come quella riguardante l’adempimento degli accordi relativi alle affissioni pubblicitarie: queste sono le missioni più semplici e più amate dal nostro «crowd». Poi ci sono missioni molto più complicate. Quest’anno abbiamo lavorato molto in giro per l’Europa con un grande gruppo automobilistico per seguire il lancio di un nuovo modello di macchina: si doveva andare nella concessionaria e avere un’interazione abbastanza prolungata e intensa con il venditore, domandandogli prezzi e disponibilità per quel modello specifico o aggiungendo una serie di optional, per vedere se l’auto era venduta bene. La stessa cosa è stata fatta anche su auto di marchi diversi.
D. Le missioni sono in incognito?
R. Per la verità la maggior parte sono in incognito, perché comunque si tratta sempre di verificare la corretta implementazione di un accordo che è stato preso dall’azienda committente della missione e quella che invece è in qualche modo oggetto della missione. Però a volte c’è anche piena apertura e trasparenza, anche perché sostanzialmente si può trattare di dati utilizzati nell’interesse del brand in questione senza che vi siano conflitti tra chi monitora e chi viene monitorato.
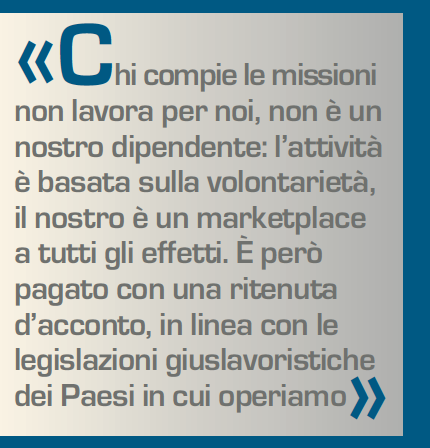
D. A quanto possono ammontare i guadagni che un Eye può fare attraverso l’App?
R. Per prima cosa tendiamo sempre a spiegare perché BeMyEye esiste: per noi è importante avere un impatto a livello globale su tutto quel segmento di persone che non ha necessariamente delle qualifiche, il cosiddetto «unskilled labour». Poi ci sono diversi livelli ed elementi di complessità nelle varie missioni, quindi bisogna impegnarsi e saperci fare, e ci teniamo in contatto attraverso un cammino che si svolge in progressione come all’interno di un videogioco – per questo lo chiamiamo «gamification» – il quale consente di salire a livelli più avanzati secondo il livello di impegno, l’ammontare delle missioni e la qualità con cui sono svolte. Le missioni possono progredire oppure ad un Eye possono essere riservate delle possibilità, come ad esempio le missioni multiple. Abbiamo notato che ci sono persone, in Francia e in Inghilterra, che si organizzano la giornata guardando quello che è possibile fare, creando un giro che permette in circa tre ore di compiere 15-20 missioni e di portarsi a casa anche 150 euro. Il nostro obiettivo principale è massimizzare le capacità di guadagno di queste persone e minimizzare l’ammontare delle ore che devono lavorare perché secondo noi, vedendo quello che è la capacità di guadagno dei nostri Eyes, è possibile essere maggiormente gratificati con un lavoro di 2-3 ore che non con un lavoro malpagato di una giornata intera.
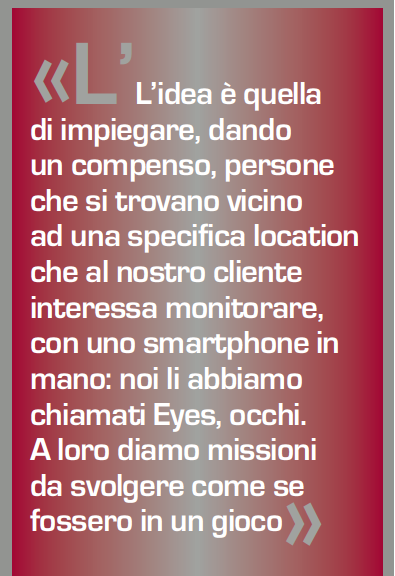
D. Si può parlare di «lavoro»? In che modo sono collocati gli Eyes sul piano fiscale?
R. Chi fa queste missioni non «lavora» per noi, non è un nostro dipendente, l’attività è basata sulla volontarietà ed il nostro è un «marketplace» a tutti gli effetti dove noi postiamo missioni specifiche e chi vuole le riserva senza nessun obbligo di svolgerle, pur se, per il concetto della «gamification», è previsto l’abbassamento di punti e la regressione ad un livello inferiore nel caso di missioni prenotate e non svolte. Non c’è una relazione di dipendenza dal punto di vista giuslavoristico, c’è invece un’elevata possibilità di guadagnare molto di più di quello che è il minimo salariale. Si tratta, a livello fiscale, di una prestazione occasionale, con la ritenuta d’acconto che tratteniamo alla fonte, pagando al netto.
D. Quindi voi pagate le tasse.
R. Assolutamente sì.
D. Gli «Eyes» devono dichiarare le entrate?
R. Possono, ma sostanzialmente sono già stati pagati al netto della ritenuta d’acconto. Il mio obiettivo è di essere assolutamente in linea con quelle che sono le legislazioni giuslavoristiche a livello nazionale. Quello che ci preme sottolineare è come questa forma di guadagno possa essere significativa, e questa per noi è una motivazione molto forte perché effettivamente possiamo incrementare l’introito di molte persone.
D. Cosa accade se, nel corso della missione, l’applicazione non funziona o ha dei problemi, come già è capitato e stato segnalato da alcuni utenti?
R. La policy è di pagare la missione svolta se anche ne caso in cui vi sia stato un problema tecnico di cui noi siamo a conoscenza o che possiamo tracciare in qualche modo dai nostri logs. Cerchiamo il più possibile di andare incontro ai nostri Eyes, soprattutto perché sappiamo che hanno impiegato del tempo; è chiaro che ciò, nella pratica, non è semplice, se non riusciamo ad avere una tracciatura di quello che realmente è successo, sapere se poi la missione può essere effettivamente pagata o meno. Quindi ciò alla fine dipende da quello che riusciamo a vedere attraverso i nostri sistemi. A fronte di una missione compiuta c’è un processo di approvazione dopo il quale è possibile effettuare il pagamento, e ci sono situazioni in cui non possiamo corrispondere la quota della missione se essa non è documentata.
D. Una contestazione di un utente su un forum online riguardava l’abbassamento del compenso nel caso di una missione in cui a lui spettava di cercare surgelati in un supermercato ed essi non fossero presenti sul banco. Se, in effetti, lo scopo ultimo della missione è quello di verificarne la presenza, e dunque l’eventuale assenza, non è una contraddizione penalizzare l’Eye?
R. Questo, in realtà, è un modo che noi usiamo per incentivare lo stesso Eye a trovare il prodotto e quindi a fare uno sforzo. A lui è concesso di inviare foto multiple di un’intera area del supermercato che ne dimostrino l’assenza, e più recentemente abbiamo sviluppato la possibilità di farlo fotografando lo scaffale su cui il prodotto dovrebbe essere presente. Se esso, invece, non è presente sullo scaffale giusto, è come se non esistesse, e costituisce un mancato adempimento del supermercato.
D. Una potenziale missione potrebbe essere quella di mettere il prodotto giusto nello scaffale giusto.
R. In verità questa potrebbe essere l’evoluzione di una missione: ad oggi ancora non lo facciamo, però sempre di più ci viene richiesto dai nostri clienti.
D. Chi sono i vostri clienti e come le trovate?
R. Sono aziende di ogni tipo, soprattutto «retail», del «consumer electronics», del settore farmaceutico, del «fast moving consumer goods» e del «personal care». Si sta intensificando la competizione delle farmacie soprattutto nei Paesi dove sono state liberalizzate e sono state acquisite le logiche del merchandising tipiche di un supermercato. Essendo lo spazio nelle farmacie limitato, è ancora più importante la corretta ubicazione dei prodotti e questo sta diventando un mercato importante per noi.

D. Dove funziona l’applicazione?
R. Sostanzialmente copre tutta l’Europa, ma recentemente abbiamo aperto in Polonia e Svezia e ci stiamo espandendo nel mercato del nord e dell’est. Essa non si limita soltanto alle grandi metropoli, ma copre ogni luogo di un Paese.
D. È possibile che in un determinato territorio non vi siano Eyes disponibili?
R. Abbiamo un modello abbastanza efficace di reclutamento di Eyes, che avviene in maniera ipergeolocalizzata sfruttando i canali di acquisizione online. Nei Paesi più avanzati dove siamo presenti da più di due anni, come l’Italia e la Francia, ormai spendiamo poco o niente in «recruiting» anche perché abbiamo un passaparola molto attivo. Oltre a ciò impieghiamo tecniche di «members-get-members», chi porta un conoscente guadagna lo stesso importo della prima missione svolta dall’amico coinvolto per suo tramite. Nei Paesi dove abbiamo appena aperto, per esempio la Polonia, facciamo un po’ di fatica ma attivando delle campagne di acquisizione e reclutamento il problema si risolve. Uno dei canali più importanti per le acquisizioni è sia il passaparola, sia Facebook. (ROMINA CIUFFA)

Anche su SPECCHIO ECONOMICO – Giugno 2017
































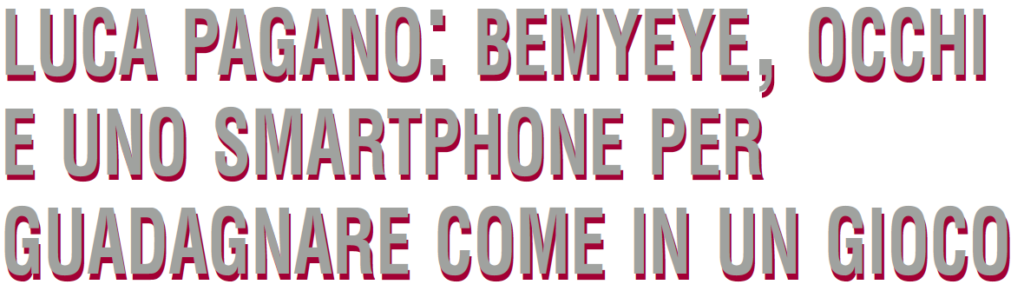

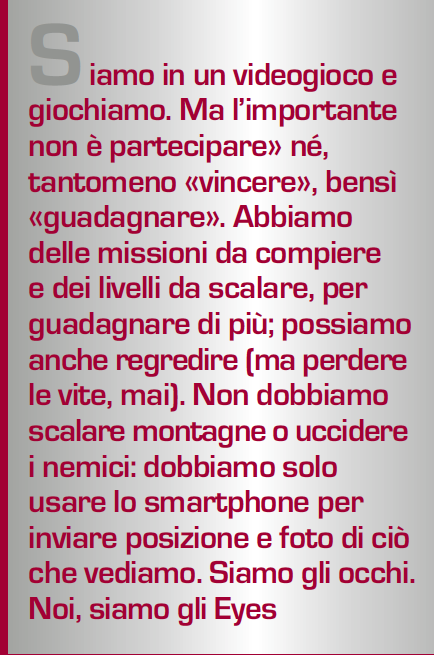


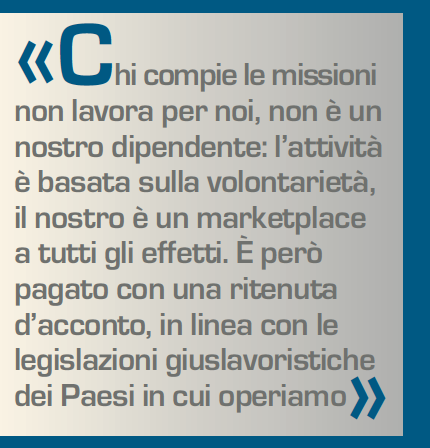
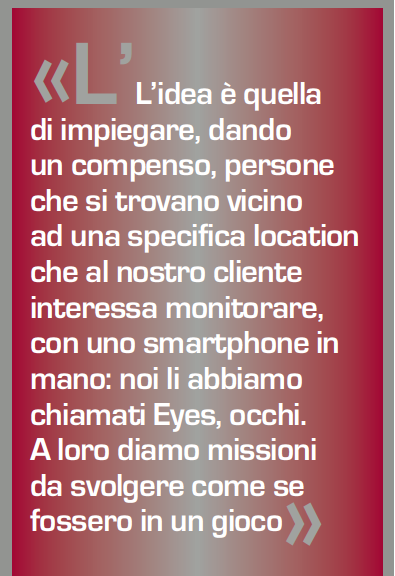








 (foto di Roberto Franciotti)
(foto di Roberto Franciotti)