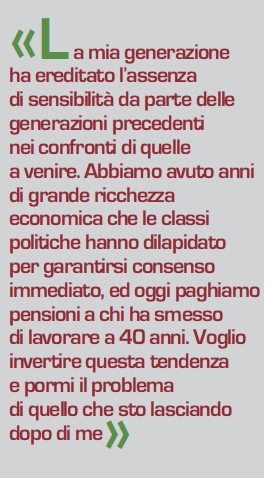Il futuro non è più quello di una volta. Lo si legge, come un brocardo, su molti muri, scritto da giovani writers inseguiti da provvedimenti che impediscono loro di fare graffiti per le città. C’è una verità formale e sostanziale in ciò che scrivono. Formale: l’arte cambia e ad essa devono adeguarsi le vecchie generazioni, i giovani hanno bisogno di esprimersi nei modi a loro più congeniali e di avere le attenzioni che la classe dirigente dedica solo a se stessa. Sostanziale: il futuro di ieri è stato pensato solo come privilegio degli adulti di oggi. Ai giovani restano precarietà, immobilizzazione, riforme sbagliate, sfiducia nel sistema, fuga di cervelli, futuro incerto. Per questo il Ministero della Gioventù è stato affidato a una giovane guida, Giorgia Meloni, classe 1977, in grado di comprendere le esigenze delle nuove generazioni senza suggestioni provenienti dal passato, ma con il pragmatismo che è il futuro a richiedere perché i giovani di oggi possano crescere.
Il futuro non è più quello di una volta. Lo si legge, come un brocardo, su molti muri, scritto da giovani writers inseguiti da provvedimenti che impediscono loro di fare graffiti per le città. C’è una verità formale e sostanziale in ciò che scrivono. Formale: l’arte cambia e ad essa devono adeguarsi le vecchie generazioni, i giovani hanno bisogno di esprimersi nei modi a loro più congeniali e di avere le attenzioni che la classe dirigente dedica solo a se stessa. Sostanziale: il futuro di ieri è stato pensato solo come privilegio degli adulti di oggi. Ai giovani restano precarietà, immobilizzazione, riforme sbagliate, sfiducia nel sistema, fuga di cervelli, futuro incerto. Per questo il Ministero della Gioventù è stato affidato a una giovane guida, Giorgia Meloni, classe 1977, in grado di comprendere le esigenze delle nuove generazioni senza suggestioni provenienti dal passato, ma con il pragmatismo che è il futuro a richiedere perché i giovani di oggi possano crescere.
Domanda. «Diritto al futuro» è, per questo Ministero, un progetto concreto. Di cosa si tratta?
Risposta. Di diritto al futuro parliamo con riferimento a un pacchetto di provvedimenti per i quali il Ministero della Gioventù ha mobilitato complessivamente 300 milioni di euro. Si tratta di una serie di iniziative tese a combattere la condizione di precarietà con la quale i giovani si confrontano giornalmente, aventi un grande comune denominatore: investire nella persona, rifiutare l’assistenzialismo generalizzato e difendere il doppio principio dell’uguaglianza e del merito. Da una parte, intendiamo costruire una società in grado di dare a tutti le medesime condizioni di partenza, rimettendo in moto l’ascensore sociale che in Italia è bloccato da una serie di rendite, privilegi, barriere; dall’altra, vogliamo che questa uguaglianza diventi presupposto per la meritocrazia: una volta garantito lo start, chi corre più veloce arriverà più lontano e prima.
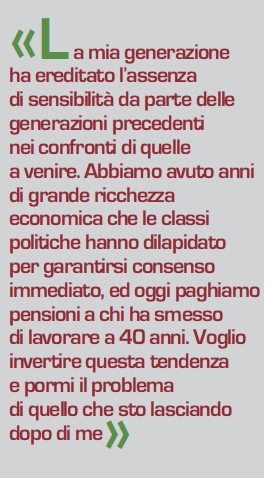
D. Quali sono i temi centrali del futuro?
R. Abbiamo affrontato, con lo stesso provvedimento, due grandi emergenze italiane: la disoccupazione giovanile e la denatalità. In Italia ci si sbraccia più sul diritto di abortire che su quello di mettere al mondo un bambino. Oggi una donna su quattro che partorisce non rientra al lavoro, la scelta della genitorialità è sempre meno popolare e i figli sono diventati un bene di lusso; per questo va premiato e incentivato il binomio responsabilità-merito, che è sotteso a una scelta tanto impegnativa. Abbiamo anche previsto un plafond di 50 milioni di euro che consente di dare a tutti gli under 35 con figli, precari o disoccupati, una dote di 5 mila euro da portare nell’azienda che li assume a tempo indeterminato.
D. Il problema della disoccupazione si aggrava. Qual’è la vostra posizione?
R. Ci siamo posti il problema del precariato e delle ragioni per cui un modello funzionante negli altri Paesi produce, nel nostro sistema, conseguenze invece inaccettabili. La difficoltà che i giovani hanno in un contesto flessibile non è data, a mio avviso, dalla loro indisponibilità ad accettare una vita lavorativa versatile, ma dall’inadeguatezza e dalle resistenze della società che li accoglie ad uniformarsi a questo cambiamento: oggi una posizione atipica rende il lavoratore «figlio di un Dio minore», poiché non garantisce le opportunità che derivano da un contratto a tempo indeterminato. Oltre al problema pensionistico, nell’immediato prevale l’incapacità del sistema di adeguarsi alle nuove forme laburistiche che, anche quando prevedano prospettive di stabilizzazione, non sono ritenute rilevanti ai fini dell’accesso al mercato del credito. Le banche non concedono mutui, la discriminazione parte da qui. Per questo abbiamo destinato 50 milioni di euro per il fondo di garanzia sull’acquisto della prima casa: lo Stato garantisce il mutuo al 70 per cento fino a 200 mila euro per giovani coppie, single con figli e giovani famiglie il cui reddito derivi per più del 50 per cento da lavoro atipico.
D. È innegabile, però, che i problemi derivati dall’incertezza investano tutti, non solo i giovani genitori, e che la genitorialità è ormai un’opzione e non più lo sviluppo naturale di un percorso medio. Ciò avviene non solo per il cambiamento dei valori in uso, ma anche e soprattutto per l’impossibilità di decidere di essere genitori senza avere un lavoro, una casa, un futuro; un circolo vizioso in cui, se i giovani non genitori non sono aiutati, difficilmente possono accollarsi la responsabilità di un figlio. Sono discriminati?
R. Questi sono problemi reali e riguardano tutti, non solo i nuclei familiari. Lo Stato però ha risorse limitate e lavora su priorità che lo portano ad investire sugli ammortizzatori sociali, lasciando prevalere il cosiddetto «favor familiae» e il problema della rigenerazione della società, ma senza per questo disconoscere i single, le coppie di fatto senza figli e le coppie omosessuali: non è una questione morale, ma esclusivamente economica.
D. Dopo gli studi, i giovani non trovano e a volte non cercano lavoro. In che modo il suo Ministero affronta il problema?
R. Ci siamo posti il problema di come aiutare a combattere il gap presente nel nostro sistema tra istruzione e mondo del lavoro, cominciando a incrementare le iniziative di job placement all’interno delle scuole e dell’università. Abbiamo portato avanti un progetto, il Global Village Campus, oggi rinominato Campus Mentis, suddividendo in cinque gruppi 600 tra i migliori laureati italiani, mettendoli per cinque settimane in contatto con i responsabili delle risorse umane del mondo imprenditoriale italiano e internazionale operativo in Italia. Tre gli obiettivi: dare un segnale ai ragazzi sull’investimento che lo Stato è in grado di compiere su di loro; mostrare al mondo imprenditoriale le capacità di questo straordinario materiale umano non sfruttato; fare formazione rispetto all’ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto pilota ci ha dato ottimi risultati: entro l’anno dal suo avvio il 77 per cento dei giovani partecipanti ha ricevuto significative proposte di lavoro. A partire da quel successo, nella seconda edizione abbiamo investito ulteriori risorse e collaborato con l’Università La Sapienza di Roma coinvolgendo 1.800 ragazzi, ossia triplicando i numeri e creando tre campus, in Veneto, in Sicilia e a Roma, che nei prossimi tre anni diverranno 20 in tutto il territorio nazionale e coinvolgeranno 20 mila ragazzi. Se il dato del 77 per cento dovesse essere trasferito da 600 a 20 mila partecipanti, parleremmo di un’iniziativa strutturale significativa. Ciò dipenderà non solo da noi, ma dalla situazione politica che troveremo.
D. All’estero i giovani escono di casa molto presto e si pagano gli studi da sé. Cos’è che blocca l’Italia?
R. L’assenza di strumenti per i nostri giovani, quale quello del «prestito d’onore». Questo resta il modo più semplice per chiamarlo, ma dovremmo cancellare dalla nostra mente l’idea che tale locuzione evoca in Italia, diversa dal resto del mondo. Nelle grandi democrazie occidentali è un sistema rodato che consente ai giovani di mantenersi da sé attraverso un prestito che poi restituiranno quando saranno nella condizione di farlo. Barack Obama ha studiato all’università grazie all’esistenza di un mondo del credito che ha investito su di lui: il presidente americano ha più volte dichiarato di aver finito di restituire il prestito da poco. Oltre al fattore economico immediato, ce n’è uno diverso: frequentare l’università sentendo il peso personale dell’indebitamento pone in una condizione psicologica diversa, che è di maggiore responsabilità. È necessario creare un’alternativa al rifugio nella solidità della famiglia. Il nostro Ministero ha dedicato agli studenti 18 milioni di euro, per finanziare una somma fino a 25 mila euro in cinque anni, dando loro l’onere della restituzione solo dopo un certo numero di anni. Questo è un provvedimento che in realtà non vorrei rifinanziare: nel mondo anglosassone lo Stato non entra minimamente, è una cosa tra privati; noi siamo costretti ad intervenire poiché è assente un tale meccanismo virtuoso, ma con ciò speriamo di dimostrare al sistema del credito che conviene investire sui ragazzi, perché domani questo circolo possa andare avanti senza l’impegno di fondi pubblici.

D. Come favorire l’imprenditoria giovanile in questo clima di pessimismo crescente?
R. Tra le nostre misure, il Fondo Mecenati riguarda il sostegno al talento e si fonda sull’alleanza tra pubblico e privato nell’investimento sugli under 35. Ogni anno in Italia alcune grandi aziende, fondazioni, organizzazioni private investono fondi propri a favore di giovani meritevoli indicendo concorsi, mettendo in palio borse di studio, portando avanti una serie di iniziative per aiutarli ad aprire un’impresa. Abbiamo deciso di riconoscere il valore sociale di tali azioni per moltiplicare le risorse, cofinanziando al 40 per cento le iniziative dei privati che investono sugli under 35 in alcuni settori che secondo noi sono strategici.
D. In che modo sviluppare la ricerca?
R. Finanziando prioritariamente gli spin off universitari, ossia la trasformazione dei risultati della ricerca in attività produttive. In Italia non trasformiamo le ricerche in attività commerciali. Dal 2000 ad oggi sono stati depositati oltre 100 mila brevetti: di questi nemmeno 700 hanno avuto un seguito. Certo non tutto ciò che viene brevettato è significativo, ma tra le 100 mila idee presentate e le 700 sviluppate è molto probabile che alcune, opportunamente monetizzate, avrebbero potuto contribuire alla nostra economia.
D. Oltre a questo pacchetto, quali altri progetti stanno maturando?
R. Ai cinque provvedimenti di «Diritto al Futuro», si aggiungono altre questioni che il Ministero della Gioventù tiene in considerazione, tra cui il coinvolgimento degli enti locali. Stiamo portando avanti discorsi a cerchi concentrici con i Comuni, le Province e le Regioni, per centrare gli stessi obiettivi, includendovi il filone della valorizzazione della cultura d’impresa. Il problema è legato all’assenza di ascensore sociale: in Italia a dar vita a un’impresa sono sempre gli imprenditori esperti, gli altri hanno la percezione che gli ostacoli da rimuovere siano troppi. Mancano informazioni e formazione su opportunità, leggi, agevolazioni, contributi, aspetti legali. Il nostro sistema di istruzione è culturamente tarato sul lavoro subordinato, che insegna a cercare lavoro e sprona poco a divenire datori. Abbiamo tentato di fare formazione con una serie di iniziative: abbiamo emesso un bando del valore di oltre 4 milioni di euro, rivolto alle associazioni studentesche che presentino progetti in collaborazione con le Università, e alle organizzazioni giovanili degli imprenditori; attualmente sono aperti in 21 Università centri per la valorizzazione della cultura di impresa, nei quali alcuni esperti accompagnano, per i primi due anni di start up, tutti i ragazzi che intendono avviare una impresa.
D. Quali altre iniziative avete preso?
R. Abbiamo dato vita a un portale, www.giovaneimpresa.it, dedicato all’imprenditoria giovanile, che offre tutte le informazioni e la consulenza necessaria gratuitamente. Ad esso collaborano tutte le associazioni giovanili imprenditoriali che ci aiutano a fare consulenza on line. Abbiamo stilato una serie di alleanze tra categorie professionali che, attraverso il Ministero della Gioventù, si sono impegnate a rivolgere ai ragazzi consulenza anche online, gratuita o alla minima tariffa. E abbiamo in cantiere un’iniziativa più strutturale che riguarda la leva fiscale: una tassazione al 10 per cento per tutte le imprese giovanili di nuova costituzione.
D. Qual’è la sfida di questo Ministero?
R. Non di certo risolvere la questione giovanile con un Ministero senza portafoglio, ma divenire l’interlocutore del Consiglio dei ministri a 360 gradi, perché in tutto quello che il Governo fa c’è un elemento che coinvolge le giovani generazioni, ossia il futuro. La mia generazione ha ereditato l’assenza di sensibilità da parte delle generazioni precedenti nei confronti di quelle a venire. Abbiamo avuto anni di grande ricchezza economica, che le classi politiche hanno dilapidato per garantirsi consenso immediato, ed oggi paghiamo pensioni a chi ha smesso di lavorare a 40 anni. Voglio invertire questa tendenza e pormi il problema di quello che sto lasciando dopo di me: in questo le riforme della scuola e dell’Università costituiscono un segnale centrale.
D. Riforma della scuola e dell’Università: qual’è la sua posizione?
R. Il problema è nella difficoltà che si incontra ogni volta che cambia un Governo: si tende a modificare il sistema esistente migliorandolo anziché annullarlo, perché ciò costerebbe di più. Prima del sistema va riformata la cultura: tendiamo a parlare di scuole e università prevalentemente per i 5 mila che all’interno vi lavorano, senza porci il problema di quelli che vi studiano e preoccupandoci più di dare posto a 10 mila insegnanti che ad impegnare gli studenti per il futuro. Oggi ci sono 327 facoltà che non hanno più di 15 studenti e 37 corsi di laurea con uno studente. Questo Governo ha fatto scelte coraggiose. Al netto della questione tagli, che è stata recuperata trattandosi, a conti fatti, di un taglio del 3 per cento che, ponendo attenzione agli sprechi delle nostre università, potrebbe esser recuperato, oggi si stanno realizzando progetti che il movimento studentesco ha sognato per 20 anni. È l’esempio del giudizio sulla qualità dell’insegnamento, delegato agli studenti. Abbiamo dovuto varare una legge per combattere prassi intollerabili e inadeguate, addirittura per dire che «chi ha una cattedra deve andare ad insegnare». Nella legge di riforma dell’università è specificato che i docenti devono firmare il tesserino, dimostrare di essere stati per un certo numero di ore all’interno dell’Università e che quelle ore siano destinate agli studenti. Abbiamo fatto una legge per dire che non possono essere inseriti parenti nelle cattedre. Ne abbiamo varato un’altra per dare maggiore credibilità al tema della ricerca, richiedendo la dimostrazione in 6 anni che la ricerca per cui si occupa un posto universitario è utile, e solo in tal caso da ricercatori si può divenire docenti o associati. Non concepiamo l’idea di ricercatore a tempo indeterminato, cosa che non succede in nessuna altra parte del mondo. Uno dei problemi è l’uso della scuola come ammortizzatore sociale riducendo, anche tramite stipendi molto bassi, l’autorevolezza e la qualità dell’insegnamento; abbiamo trasformato i nostri docenti nei peggiori d’Europa e questo ha anche abbattuto la loro passione nel proprio mestiere. Abbiamo abolito una serie di sperimentazioni, dato vita a una semplificazione del sistema e rimesso in piedi tutta la grande questione degli istituti tecnici e professionali. Insegnavano una divisione tra «chi pensa» e «chi fa», ed ora è necessario rivalorizzare la creatività dei secondi, gli unici in grado, nelle specificità italiane, di non essere soggetti alla concorrenza cinese. Se riuscissimo ad avviare un’offensiva culturale per restituire valore a chi crea, avremmo posti di lavoro già disponibili per una serie di mestieri legati all’artigianato. È necessario tornare all’umiltà. Può capitare di dover fare un lavoro meno prestigioso di quello per cui si è preparati, ma è solo un passaggio di cui il Paese ha bisogno per andare avanti con l’economia, che rispecchia la cultura della gavetta iniziale.
D. Gli italiani restano ancora a casa?
R. Sono molte più le donne, rispetto agli uomini, ad uscire dalla casa familiare prima dei 34 anni. Ciò non è nemmeno legato alle opportunità, perché le donne storicamente ne hanno meno degli uomini, bensì si ricollega alla maggiore autodeterminazione femminile che non rende drammatico l’impatto con l’indipendenza.
D. I giovani avranno la pensione?
R. La nostra generazione avrà le pensioni, ma non quelle che conoscevamo: andremo in pensione non prima dei 65 anni e la nostra sarà presumibilmente più bassa di quella che avremmo avuto con il sistema retributivo. Pochi di noi arriveranno a prendere l’80 per cento della retribuzione come prevedeva il sistema retributivo. Oggi le pensioni sono assolutamente inadeguate, vanno fatte riforme strutturali e combattute una serie di discriminazioni tra contratti di lavoro subordinato e nuove forme di flessibilità.
D. L’obiettivo primario del Ministero?
R. Lavorare sulle competenze e rendere la nuova generazione più valida di quella precedente. (ROMINA CIUFFA)

Anche su SPECCHIO ECONOMICO – Febbraio 2011











 Il futuro non è più quello di una volta. Lo si legge, come un brocardo, su molti muri, scritto da giovani writers inseguiti da provvedimenti che impediscono loro di fare graffiti per le città. C’è una verità formale e sostanziale in ciò che scrivono. Formale: l’arte cambia e ad essa devono adeguarsi le vecchie generazioni, i giovani hanno bisogno di esprimersi nei modi a loro più congeniali e di avere le attenzioni che la classe dirigente dedica solo a se stessa. Sostanziale: il futuro di ieri è stato pensato solo come privilegio degli adulti di oggi. Ai giovani restano precarietà, immobilizzazione, riforme sbagliate, sfiducia nel sistema, fuga di cervelli, futuro incerto. Per questo il Ministero della Gioventù è stato affidato a una giovane guida, Giorgia Meloni, classe 1977, in grado di comprendere le esigenze delle nuove generazioni senza suggestioni provenienti dal passato, ma con il pragmatismo che è il futuro a richiedere perché i giovani di oggi possano crescere.
Il futuro non è più quello di una volta. Lo si legge, come un brocardo, su molti muri, scritto da giovani writers inseguiti da provvedimenti che impediscono loro di fare graffiti per le città. C’è una verità formale e sostanziale in ciò che scrivono. Formale: l’arte cambia e ad essa devono adeguarsi le vecchie generazioni, i giovani hanno bisogno di esprimersi nei modi a loro più congeniali e di avere le attenzioni che la classe dirigente dedica solo a se stessa. Sostanziale: il futuro di ieri è stato pensato solo come privilegio degli adulti di oggi. Ai giovani restano precarietà, immobilizzazione, riforme sbagliate, sfiducia nel sistema, fuga di cervelli, futuro incerto. Per questo il Ministero della Gioventù è stato affidato a una giovane guida, Giorgia Meloni, classe 1977, in grado di comprendere le esigenze delle nuove generazioni senza suggestioni provenienti dal passato, ma con il pragmatismo che è il futuro a richiedere perché i giovani di oggi possano crescere.