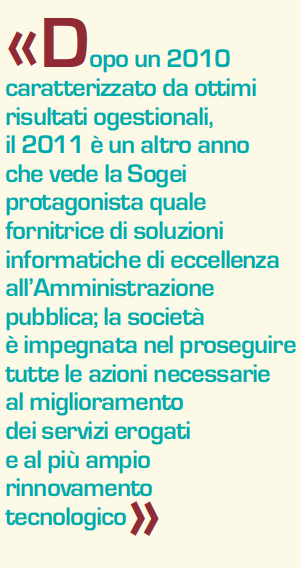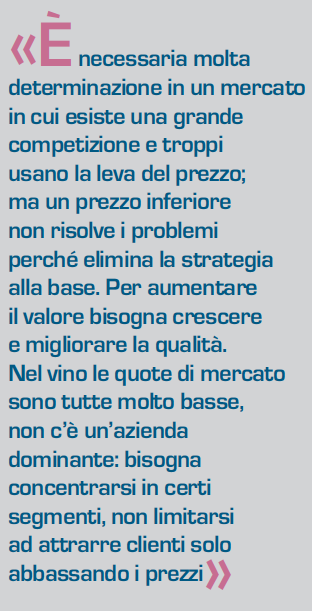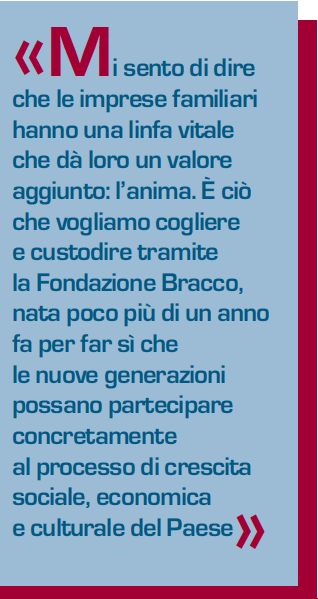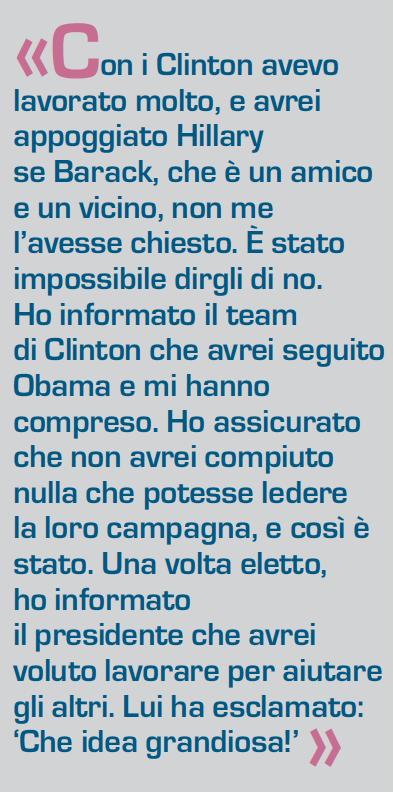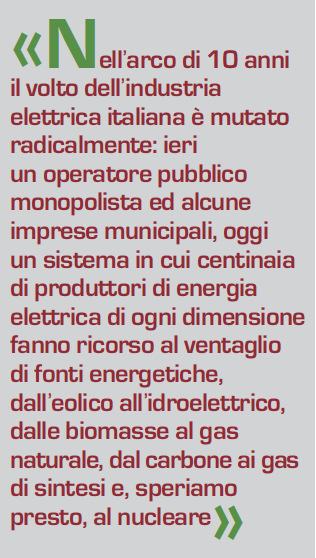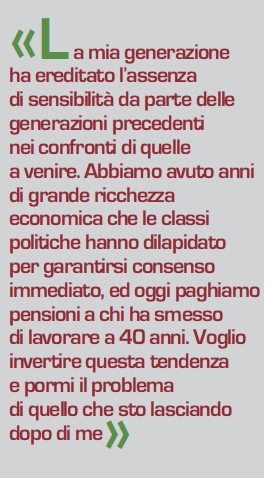AMMIRAGLIO MARCO BRUSCO: GUARDIA COSTIERA E CAPITANERIA DI PORTO, UN MARE DI SICUREZZA
 Una donna in ogni porto significa qualcosa di diverso dal solito stereotipo del marinaio: la Capitaneria di Porto oggi, infatti, è dotata di una forte componente femminile, donne che sono in prima linea nelle più complesse operazioni della Guardia Costiera. Fatta luce su ciò, altri quesiti: quale differenza c’è tra Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, locuzioni talvolta impiegate confusamente nella terminologia comune? E l’emergenza ambiente: cosa sta facendo l’Italia per prevenire i gravi incidenti in mare che mettono a repentaglio la salute delle nostre coste e della stessa popolazione? Risponde l’Ammiraglio Ispettore Capo Marco Brusco, dall’8 ottobre 2010 Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, facendo il punto sulla situazione dei mari italiani.
Una donna in ogni porto significa qualcosa di diverso dal solito stereotipo del marinaio: la Capitaneria di Porto oggi, infatti, è dotata di una forte componente femminile, donne che sono in prima linea nelle più complesse operazioni della Guardia Costiera. Fatta luce su ciò, altri quesiti: quale differenza c’è tra Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, locuzioni talvolta impiegate confusamente nella terminologia comune? E l’emergenza ambiente: cosa sta facendo l’Italia per prevenire i gravi incidenti in mare che mettono a repentaglio la salute delle nostre coste e della stessa popolazione? Risponde l’Ammiraglio Ispettore Capo Marco Brusco, dall’8 ottobre 2010 Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, facendo il punto sulla situazione dei mari italiani.
Domanda. Il 20 luglio scorso la Capitaneria di Porto ha celebrato il 146esimo anniversario. In che modo?
Risposta. Ci vantiamo nel dire che la Capitaneria di Porto, nata ufficialmente per volontà di Cavour che ne firmò il decreto istitutivo, è la prima istituzione creata dal nuovo Stato d’Italia. Abbiamo voluto legare la celebrazione a una mostra storica sulle Capitanerie di Porto nei 150 anni d’Italia, e ad una mostra fotografica su Lampedusa dedicata al fenomeno migratorio e all’opera di soccorso svolta dalla Guardia Costiera. A rafforzare la collaborazione tra lo Stato italiano e quello panamense, sancita nel giugno 2010, durante la cerimonia del 20 luglio scorso, abbiamo consegnato alla Guardia costiera del Paese centro-americano due delle quattro unità navali previste.
D. Quale differenza c’è tra Capitaneria di Porto e Guardia Costiera?
R. Prima c’era solo la Capitaneria di Porto. Nel 1989 i reparti del Corpo delle Capitanerie di Porto che svolgono compiti di natura tecnico-operativa sono stati costituiti in Guardia Costiera. Questa, pertanto, rappresenta un’articolazione del Corpo. Il provvedimento, in realtà, non ha fatto altro che riconoscere un servizio da sempre svolto, lungo le coste e in mare, dalle Capitanerie, ma ha evidenziato l’aspetto operativo della Guardia Costiera per assimilarlo a quello che normalmente l’utente immagina anche attraverso il frasario internazionale sui soccorsi in mare, sulla sicurezza della navigazione etc. La Capitaneria di Porto nacque con una finalità amministrativa dei porti e delle coste, e noi teniamo molto a questo carattere iniziale. Da quando sono Comandante generale ricordo ai miei entusiasti giovani che siamo 11 mila persone e che, sebbene l’aspetto operativo sia affascinante, la nostra radice è amministrativa marittima. Abbiamo avuto la responsabilità delle coste prima che gli enti locali venissero delegati alla gestione del demanio marittimo, e abbiamo svolto un ottimo lavoro che ci rende orgogliosi. Anche la stessa utenza a volte ci rimpiange.
D. Quali legami ha la Capitaneria di Porto con le istituzioni governative?
R. Nel 1919 il Corpo fu militarizzato per volontà del Parlamento e del Governo, e dal 1923, quando venne incluso nella Regia Marina, è rimasto legato alla Marina Militare mantenendo però una particolarità: quella di espletare la maggior parte del proprio lavoro alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prima denominato della Marina mercantile. Svolgiamo anche determinate funzioni per il Ministero dell’Ambiente e per le Risorse Agricole e Forestali nel settore della pesca marittima; infine ci occupiamo di altre mansioni anche a favore di altri Ministeri. Rimane fermo il legame con il Ministero della Difesa nei nostri compiti militari o di collaborazione con la Forza Armata.

D. Quali sono in particolare i rapporti con la Marina Militare?
R. I rapporti, in alcuni contesti operativi, rimangono essenzialmente di complementarietà; la Marina si pone a difesa degli interessi nazionali e di protezione della libera navigazione, garantisce la sicurezza delle linee di traffico, contrasta la pirateria e il terrorismo, mentre le Capitanerie hanno ruoli specifici, derivanti da competenze di dicasteri diversi da quello della Difesa, quali la ricerca e il soccorso in mare e nei laghi maggiori, il controllo delle attività di pesca, la tutela ambientale, l’antinquinamento, la sicurezza dei porti, della navigazione e del trasporto marittimo, la polizia giudiziaria a competenza speciale, il concorso nel controllo dell’immigrazione clandestina via mare, il concorso nella protezione civile. Sempre più spesso la sinergia che scaturisce dalla dipendenza delle Capitanerie dalla Marina si manifesta nella condivisione dei dati sul traffico marittimo, nell’espletamento delle attività concorsuali e nello scambio di informazioni durante le attività operative di pattugliamento, sorveglianza e controllo svolte in mare dalle singole unità operative.
D. Tra tanti, quali sono i compiti in cui più vi identificate?
R. Il salvataggio delle vite umane in mare. Nelle nostre centrali operative usiamo un sistema molto moderno: anni fa abbiamo recepito la Convenzione d’Amburgo che istituiva un Centro di responsabilità nazionale presso il Comando generale di Roma, che dirigo alle dirette dipendenze del ministro dei Trasporti. Oltre a ciò abbiamo 15 Direzioni marittime inclusa l’Autorità dello Stretto di Messina, 54 Capitanerie di Porto, 48 Uffici circondariali marittimi, 126 Uffici locali marittimi e 38 Delegazioni di spiaggia. I sottocentri di responsabilità creano una rete tale da consentirci di conoscere immediatamente qualsiasi cosa avvenga nel territorio costiero o nel nostro mare, direttamente o attraverso le sedi periferiche. Da qualche anno abbiamo anche una competenza sui laghi maggiori.
D. Qual è l’impegno internazionale della Guardia Costiera?
R. Negli ultimi tempi, in ragione di rinnovate potenzialità acquisite, consistenti in mezzi navali e aerei, la Guardia Costiera ha operato in missioni ad ampio raggio di carattere internazionale, come quelle di disinquinamento svolta in Libano per conto del Ministero dell’Ambiente e in Senegal per contrastare l’immigrazione clandestina per conto del Ministero dell’Interno e sotto l’egida dell’Agenzia europea Frontex.
D. Quali mezzi impiegate in mare?
R. Usiamo motovedette di vario tipo; quelle d’altura ci sono servite molto anche in ambito Frontex all’estero, in Senegal, Grecia e Turchia, ma sono utili anche all’attività di controllo in alto mare o nei limiti del mare territoriale. Nel caso dei migranti impieghiamo le vedette SAR, (Search and Rescue) che sono veloci e consentono di intervenire con qualsiasi condizione meteo marina. Ora abbiamo una nuova barca, la Classe 300 Ammiraglio Francese, auto-raddrizzante: ritengo che il loro impiego sia stato decisivo per gli eventi delle Isole Pelagie. Abbiamo in programma di dotare l’Italia di un certo numero di motovedette Classe 300 per il «gioco degli incastri» da noi definito «maglia a triangoli», in base al quale se accade qualcosa, interviene nel tempo minore la vedetta che si trova nella posizione più vicina. Abbiamo barche destinate a impieghi più specifici, come l’attività di polizia sottocosta. Nella stagione estiva è utile un mezzo più snello e con minore equipaggio a bordo, e i gommoni veloci sono usati per attività ambientali o di vigilanza costiera. Abbiamo in costruzione da parte della Fincantieri 2 pattugliatori di circa 90 metri e un Supply Vessel per attività di polizia marittima in realizzazione presso un cantiere napoletano che dovrebbe essere operativo nel giro di un anno e mezzo.
D. Di quali mezzi aerei siete dotati?
R. Ora stiamo impiegando tre velivoli Atr 42, in attesa di averne un quarto. La componente elicotteristica invece, dislocata nelle basi di Sarzana e di Catania, consta di nove elicotteri AB412 e di quattro AW139.
D. Com’è svolto l’addestramento?
R. Per noi è essenziale. Il nostro personale deve avere due molle: la prima è costituita dalla formazione stessa, la seconda da una costante carica psicologica. La formazione di base è svolta negli Istituti di formazione della Forza Armata con il conseguimento del titolo accademico al termine del corso, sia da parte degli ufficiali nell’Accademia Navale di Livorno sia dei marescialli nella Scuola Sottufficiali di Taranto. I primi, tramite una convenzione stipulata con l’Università di Pisa, conseguono la laurea in Scienze del governo e dell’amministrazione del mare; i marescialli, grazie alla nuova convenzione stipulata con l’Università di Bari, conseguono la laurea triennale in Scienze e Gestione delle attività marittime con indirizzo ambientale. Per ciò che concerne la formazione specialistica, essa è mirata ai settori di interesse del Corpo ed è svolta, in relazione alle risorse disponibili, sia in autonomia con docenza da parte di ufficiali e sottufficiali nel comprensorio Gregoretti della Direzione marittima di Livorno sia presso enti esterni. Nel corso del 2011 il Corpo si doterà di un ulteriore comprensorio nella sede di Messina per la formazione del personale «in house» relativa a due temi significativi quali il VTS e il SAR. È prevista l’acquisizione di una nave a vela, che gli allievi impiegheranno dal 2012. Inoltre svolgiamo corsi periodici nei centri della Marina Militare tra la Maddalena e Taranto, predisponiamo master e curiamo l’apprendimento di una seconda lingua che è prevalentemente l’inglese e in qualche caso il francese e lo spagnolo; abbiamo anche un allievo e un’allieva che parlano l’arabo.
D. Ha citato il «VTS», che cosa è?
R. VTS è l’acronimo di Vessel Traffic Service, un servizio di informazione e di ausilio alla navigazione reso alle navi al fine di prevenire incidenti in mare. Questo servizio confluisce in un sistema più complesso, denominato VTMIS (Vessel traffic management information system), che unisce i diversi sistemi di monitoraggio del traffico marittimo in un unico sistema i cui dati possono essere condivisi con altre organizzazioni ed enti della Pubblica Amministrazione.
D. Quali risultati ha ottenuto finora questo sistema?
R. Ha dimostrato un elevato livello di efficienza. Le aree marittime particolarmente sensibili sono già state sottoposte a monitoraggio continuo: è il caso dello Stretto di Messina, dell’area delle Bocche di Bonifacio, dell’area della Sicilia occidentale e meridionale, del complesso portuale della Liguria, delle zone in cui si trovano le rotte di accesso e di uscita dal Mare Adriatico e delle aree dove sono i principali porti che trattano prodotti petroliferi e merci pericolose. Questo sistema è particolarmente utile anche in caso di situazioni di emergenza e soccorso in mare: un sistema di allarme a bordo permette infatti di mettere in contatto la nave con la centrale Operativa del Comando Generale in Roma e quindi di seguire in tempo reale l’evolversi delle fasi dell’emergenza.
D. Qual’è la situazione relativa alle donne nel vostro Corpo?
R. Non abbiamo problematiche particolari con l’elemento femminile, anzi le donne sono incentivate e ricoprono anche incarichi di rilievo, lo stesso capo della mia Segreteria Particolare è una donna. Molte sono attualmente in comando con il grado di tenente di vascello: devo dire con molto orgoglio che le ragazze dimostrano di essere ottimi comandanti anche nelle zone più difficili, ad esempio nel Napoletano, dove ci sono ben tre di loro.
D. In che modo la vostra struttura informa gli utenti delle proprie attività?
R. Punto molto sul valore della comunicazione, sulla quale abbiamo compiuto passi da gigante. Poiché facciamo un buon lavoro per la collettività, è giusto che esso sia reso noto con ogni mezzo all’utenza. In passato è capitato di non aprirsi ai media, forse per il timore di parlare all’esterno dell’Organizzazione; io ritengo invece che quanta più comunicazione viene effettuata, tanto più si garantisce trasparenza e si riesce a far capire cos’è il nostro Corpo e dove vuole andare. Diamo pubblicamente risposte molto precise: Lampedusa è il caso più eclatante nel quale il lavoro dei nostri uomini è stato riconosciuto per la qualità dal Capo dello Stato italiano e dal responsabile dell’UNHCR (United Nations High Commisioner for refuges). Sono del parere che il linguaggio usato per comunicare deve essere quello di tutti non il nostro, tanto che, quando ero al comando sia a Genova che a Livorno, spesso invitavo i giornalisti in Capitaneria per insegnare ai nostri giovani l’uso del linguaggio.
D. Avete predisposto una campagna per i giovani studenti. Com’è nata l’idea?
R. Spesso sono i figli a fare educazione nelle famiglie, soprattutto per quanto attiene l’ambiente o la cultura del mare: per questo siamo entrati a parlare di tali argomenti nelle scuole elementari e medie. Nei licei i ragazzi sono più disincantati e distaccati, i bambini sono invece più curiosi e interessati. Abbiamo ottenuto risultati sorprendenti incredibili, tanto da essere invitati e coinvolti in varie iniziative dalle stesse scolaresche.
D. Siete anche nel web?
R. Si. Il nostro sito www.guardiacostiera.it, di facile consultazione, contiene tutte le informazioni utili per l’utenza. Anche ad esso affidiamo la divulgazione del decalogo per un buon uso del mare e delle sue risorse biologiche, pubblicando sul web anche le ordinanze sulla sicurezza della balneazione. Abbiamo da sempre emanato «ordinanze balneari» per il buon comportamento e siamo stati i primi ad adottare, attraverso esse, le regole per il rispetto dell’ambiente marino. Questo ci ha fatto diventare i primi ecologisti italiani. Naturalmente, è importante anche la comunicazione interna che curiamo attraverso lo specifico portale.
D. Durante l’estate è stato attivo il progetto «Mare sicuro 2011», operazione della Guardia costiera per prevenire gli incidenti in mare. Di che si è trattato?
R. Nel progetto, caratterizzato da stagionalità, oltre ai 3 mila militari abilitati al salvamento, sono state impegnate 200 unità navali e pattuglie a terra lungo le coste e i maggiori laghi italiani. Sono stati intensificati i controlli per il rispetto dei limiti di velocità e delle aree riservate alla balneazione, senza dimenticare la tutela dell’ambiente marino. Siamo per la prevenzione più che per la repressione.
D. Quali sono le principali cause degli incidenti in mare?
R. Sono due: l’imprudenza e la scarsa conoscenza delle norme, a volte tecniche e di difficile comprensione per l’utente medio. Per ridurre gli incidenti c’è bisogno di un’azione informativa il più possibile chiara e capillare. Occorre trasmettere in modo comprensibile i principi basilari della cultura nautica.
D. Ricordando l’incidente della petroliera Erika naufragata nel 1999 che, per cedimenti e deficienze strutturali, riversò sulle coste dell’Atlantico 20 mila tonnellate di olio combustibile causando una delle più gravi catastrofi ecologiche e un danno valutabile in 200 milioni di euro, cosa può dire sulla sicurezza delle navi?
R. In passato la presenza in mare di navi al di sotto degli standard di sicurezza è stata spesso causa di incidenti; necessità primaria è stata quella di creare organismi di controllo internazionali, sensibilizzando gli Stati d’approdo al fine di verificare l’integrità degli scafi battenti bandiera estera, con particolare attenzione per quelli più obsoleti. Il «Port State Control» è quindi il potere di uno Stato di sottoporre a verifica le navi straniere che fanno scalo nei propri porti, per accertarne la conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza della navigazione, di antinquinamento e di condizioni di vita a bordo, nonché la corrispondenza alle norme nazionali applicabili. L’organizzazione nazionale PSC in Italia è affidata alle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Secondo il rapporto 2010 del Paris MOU, solo in Italia le navi ispezionate sono state 2000, di cui 121 non autorizzate a ripartire sino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Risultati che confermano l’Italia ai primi posti nella classifica dei Paesi con i migliori risultati stilata dal Paris MOU. (ROMINA CIUFFA)

Anche su SPECCHIO ECONOMICO – Settembre 2011



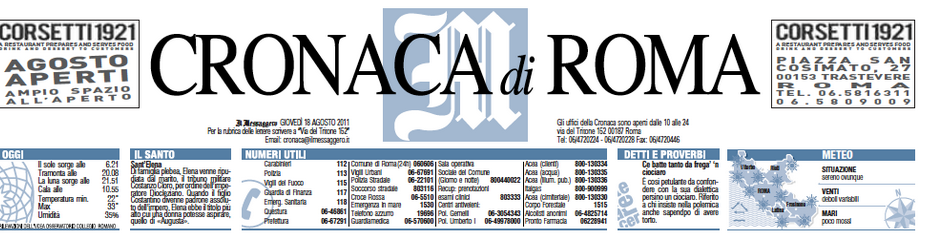
 PANDEIROMANI di Romina Ciuffa. “Painderomani” è la definizione giusta. Come altro riferirsi alla mania capitolina per il pandeiro in un’unica parola che racchiuda Brasile, mani e romanità? Con una premessa: il Brasile romano non è solo prorompenti ballerine per manifestazioni estive o transessualismo ad uso e consumo della pagina politica. Tutt’altro: c’è un intero mondo che batte su tamburi di legno e balla Samba, Pagode e Forrò, proprio ora che in Brasile è inverno. Così la contro-estate de’ noantri è iniziata con la Festa Junina, quella in onore di São João, quintessenza dell’inverno brasiliano che segue la tradizione del Forrò, ballo il cui nome deriva dall’inglese “for all” proprio ad indicare una fruibilità universale; a Tor di Quinto si è riprodotta l’intera Quadrilha con i suoi riti contadini, accompagnati da cibo tipico, artigianato, churrasco.
PANDEIROMANI di Romina Ciuffa. “Painderomani” è la definizione giusta. Come altro riferirsi alla mania capitolina per il pandeiro in un’unica parola che racchiuda Brasile, mani e romanità? Con una premessa: il Brasile romano non è solo prorompenti ballerine per manifestazioni estive o transessualismo ad uso e consumo della pagina politica. Tutt’altro: c’è un intero mondo che batte su tamburi di legno e balla Samba, Pagode e Forrò, proprio ora che in Brasile è inverno. Così la contro-estate de’ noantri è iniziata con la Festa Junina, quella in onore di São João, quintessenza dell’inverno brasiliano che segue la tradizione del Forrò, ballo il cui nome deriva dall’inglese “for all” proprio ad indicare una fruibilità universale; a Tor di Quinto si è riprodotta l’intera Quadrilha con i suoi riti contadini, accompagnati da cibo tipico, artigianato, churrasco.



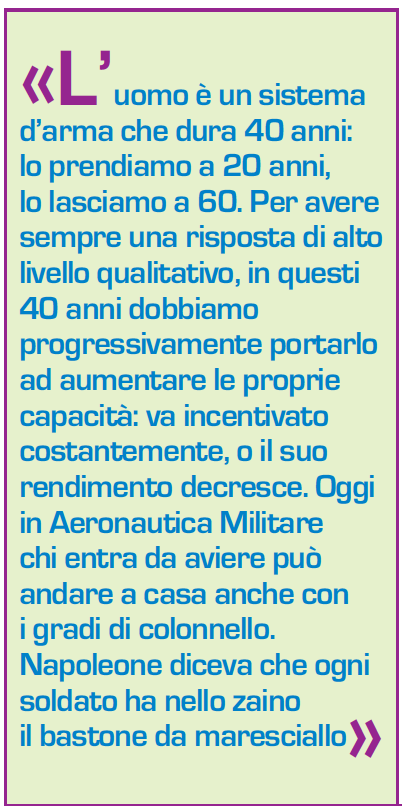




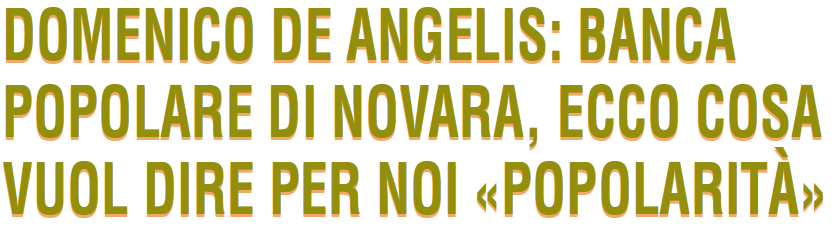
 Il credito popolare affonda le proprie radici nell’Europa del XIX secolo, come risposta alle difficoltà di accesso al credito della piccola imprenditoria urbana e rurale. Fin dalle prime associazioni di credito promosse dal politico ed economista Franz Hermann Schulze-Delitzsch e da Federico Guglielmo Raiffeisen, ispiratore del movimento cooperativistico e mutualistico delle casse rurali in Europa a fine ‘800, il modello organizzativo popolare si ispirò ai principi di democrazia societaria e di finalità mutualistica. Nel corso del tempo questo modello si è evoluto e oggi le banche cooperative rappresentano una forza di primo piano per il settore bancario europeo, forte di 140 milioni di clienti e di una quota di mercato del 20 per cento. In Italia, le Banche Popolari nascono nella seconda metà del XIX secolo per iniziativa dell’economista Luigi Luzzatti e con la fondazione, per opera del politico e banchiere Tiziano Zalli, della prima Banca Popolare, quella di Lodi fondata nel 1864. Coerentemente con i principi ispiratori, con il caratteristico assetto cooperativo e con la particolare attenzione rivolta alla piccola imprenditoria e alle famiglie, il modello del credito popolare ha i propri cardini in tre punti: nella democrazia partecipativa attraverso il sistema del voto capitario («una testa, un voto»), nella trasparenza della gestione, necessaria per ottenere il consenso di una vasta platea di soci e nella vicinanza alla clientela derivante dalla vocazione localistica che fa del radicamento territoriale e della conoscenza della clientela dei punti di forza.
Il credito popolare affonda le proprie radici nell’Europa del XIX secolo, come risposta alle difficoltà di accesso al credito della piccola imprenditoria urbana e rurale. Fin dalle prime associazioni di credito promosse dal politico ed economista Franz Hermann Schulze-Delitzsch e da Federico Guglielmo Raiffeisen, ispiratore del movimento cooperativistico e mutualistico delle casse rurali in Europa a fine ‘800, il modello organizzativo popolare si ispirò ai principi di democrazia societaria e di finalità mutualistica. Nel corso del tempo questo modello si è evoluto e oggi le banche cooperative rappresentano una forza di primo piano per il settore bancario europeo, forte di 140 milioni di clienti e di una quota di mercato del 20 per cento. In Italia, le Banche Popolari nascono nella seconda metà del XIX secolo per iniziativa dell’economista Luigi Luzzatti e con la fondazione, per opera del politico e banchiere Tiziano Zalli, della prima Banca Popolare, quella di Lodi fondata nel 1864. Coerentemente con i principi ispiratori, con il caratteristico assetto cooperativo e con la particolare attenzione rivolta alla piccola imprenditoria e alle famiglie, il modello del credito popolare ha i propri cardini in tre punti: nella democrazia partecipativa attraverso il sistema del voto capitario («una testa, un voto»), nella trasparenza della gestione, necessaria per ottenere il consenso di una vasta platea di soci e nella vicinanza alla clientela derivante dalla vocazione localistica che fa del radicamento territoriale e della conoscenza della clientela dei punti di forza.



 Società operante nel settore delle tecnologie informatiche appartenente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Sogei è impegnata da oltre trent’anni a contribuire alla modernizzazione del Paese mettendo a disposizione del settore pubblico il patrimonio di conoscenze e di esperienze tecnologiche, organizzative e fiscali acquisite, ai fini di una maggiore semplificazione delle procedure amministrative e di una più ampia integrazione tra le pubbliche amministrazioni. Anche in ambito internazionale l’azienda svolge un ruolo rilevante per lo sviluppo dell’e-Government e per il superamento del digital divide attraverso la diffusione delle migliori best practice. Già presidente della Sogei dal 2001 al 2006 e rieletto con la stessa carica nel luglio 2008, Sandro Trevisanato è uno dei pochi oggi in grado di descrivere come si è modificato il ruolo della società nei suoi oltre trent’anni di attività. «Nacque nel 1976 con l’obiettivo di realizzare una moderna anagrafe tributaria; di proprietà prima del Gruppo Iri, poi di Telecom Italia; nel 2002 fu acquisita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene il 100 per cento, e fino a quel momento l’attività era prevalentemente concentrata nel settore fiscale», ricorda.
Società operante nel settore delle tecnologie informatiche appartenente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Sogei è impegnata da oltre trent’anni a contribuire alla modernizzazione del Paese mettendo a disposizione del settore pubblico il patrimonio di conoscenze e di esperienze tecnologiche, organizzative e fiscali acquisite, ai fini di una maggiore semplificazione delle procedure amministrative e di una più ampia integrazione tra le pubbliche amministrazioni. Anche in ambito internazionale l’azienda svolge un ruolo rilevante per lo sviluppo dell’e-Government e per il superamento del digital divide attraverso la diffusione delle migliori best practice. Già presidente della Sogei dal 2001 al 2006 e rieletto con la stessa carica nel luglio 2008, Sandro Trevisanato è uno dei pochi oggi in grado di descrivere come si è modificato il ruolo della società nei suoi oltre trent’anni di attività. «Nacque nel 1976 con l’obiettivo di realizzare una moderna anagrafe tributaria; di proprietà prima del Gruppo Iri, poi di Telecom Italia; nel 2002 fu acquisita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene il 100 per cento, e fino a quel momento l’attività era prevalentemente concentrata nel settore fiscale», ricorda.